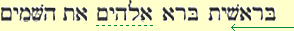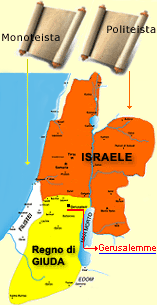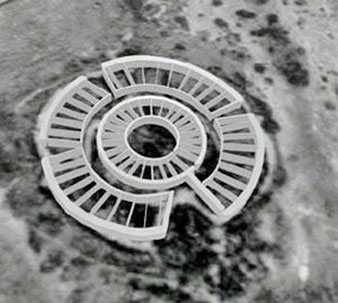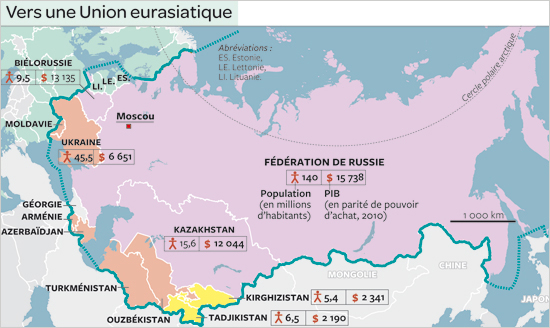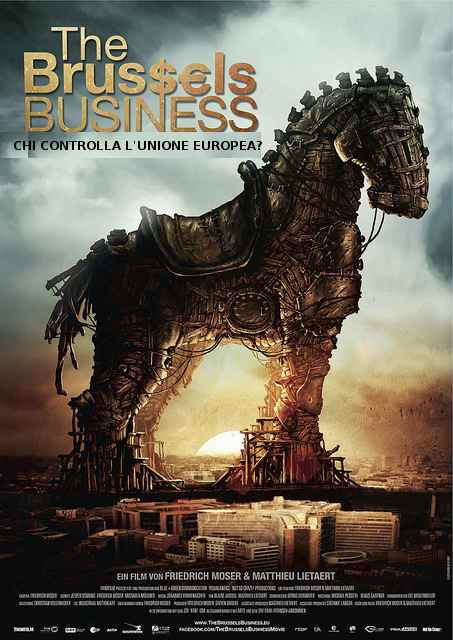Quando Hitler sale al potere, la Germania soffre di una crisi industriale enorme, paragonabile a quella americana, con la relativa gigantesca disoccupazione. Ma a differenza degli Stati Uniti, per di più è gravata da debiti esteri schiaccianti. Non solo il debito politico, il peso delle riparazioni; anche il debito commerciale è pauroso.
Le sue riserve monetarie sono ridotte quasi a zero.
Inoltre, s’è prosciugato totalmente il flusso dei capitali esteri, che si presumevano necessari alla sua rinascita economica. La Germania insomma non ha denaro,ha perso i suoi mercati d’esportazione, è forzatamente isolata - dalla recessione mondiale - dal mercato globale. Costretta a un’economia a circuito chiuso, nei suoi angusti confini.
Ma proprio da lì, comincia a rinascere. Come?
Secondo Rauschning, i nazisti “si basavano sulle idee sempliciste del loro fuehrer, e s’erano creati una teoria monetaria che suonava pressappoco così: le banconote si possono moltiplicare e spendere a volontà,purché si mantengano costanti i prezzi”.
Hitler lo diceva con esplicita brutalità: “dopo l’eliminazione degli speculatori e degli ebrei, si dispone di una sorta di moto perpetuo economico, di circuito chiuso il cui movimento non si arresta mai. Il solo motore necessario per questo meccanismo è la fiducia. Basta creare e mantenere questa fiducia, sia con la suggestione sia con la forza o con entrambe” (3)
Sono idee sempliciste. O anche assurde sul piano della teoria economica: creare inflazione (stampare carta moneta) senza far salire i prezzi - e senza ricorrere al razionamento dei consumi, alle tessere del pane, come stava facendo Stalin negli stessi anni.
Eppure funzionano.
A causa del suo grande indebitamento estero, la Germania non può svalutare la moneta: questa misura renderebbe più competitive le sue esportazioni, ma accrescerebbe il peso del debito. Fra le prime misure del Terzo Reich c’è dunque il riequilibrio del commercio, perché il deficit commerciale non può più essere finanziato come si fa in periodi normali. Di fatto, la libertà di scambio viene sostituita da Hitler da meccanismi inventivi.
I creditori della Germania vengono pagati con marchi (stampati apposta, moneta di Stato) che però devono essere utilizzati solo per comprare in Germania merci tedesche.
Ben presto, questo sistema sviluppò, quasi spontaneamente, accordi internazionali di scambio per baratto: la Germania non aveva più bisogno di valuta estera (dollari o sterline) per comprare le materie prime di cui necessitava, perché non vendeva né comprava più.
Per il grano argentino, dava in cambio i suoi (pregiati) prodotti industriali; per il petrolio dei Rockefeller, armoniche a bocca e orologi a cucù.
Prendere o lasciare, e le condizioni di gelo del mercato globale non consentivano ai Rockefeller di fare i difficili.
Per i pochi commerci con esborso di valuta, il Reich impose agli importatori tedeschi un’autorizzazione della Banca Centrale all’acquisto di divise estere; il tutto presto fu facilitato da accordi diretti con gli esportatori, che disponevano di quelle divise e le mettevano a disposizione. I negozi sui cambi avvenivano dunque, “dopo l’eliminazione degli speculatori e degli ebrei”, senza che fosse necessario pagare il tributo ai banchieri internazionali.
Controllo statale dei cambi e del commercio estero sono praticati nello stesso periodo dall’Urss, con atroce durezza: ma con risultati miserandi.
Il controllo nazista dei cambi e dei commerci esteri invece, deve ammettere lo storico, “dà alla politica economica tedesca una nuova libertà”.
Anzitutto, perché il valore interno del marco (il suo potere d’acquisto per i lavoratori) è stato svincolato dal suo prezzo esterno, quello sui mercati valutari anglo-americani.
Lo Stato tedesco può dunque praticare politiche inflazioniste, stampando la moneta di cui ha bisogno, senza essere immediatamente punito dai mercati mondiali dei cambi (governati da speculatori ed ebrei) con una perdita del valore del marco rispetto al dollaro. E il pubblico tedesco non riceve quel segnale di sfiducia mondiale consistente nella svalutazione del cambio della sua moneta nazionale.
Così, Hitler può stampare marchi nella misura che desidera per raggiungere il suo scopo primario: il riassorbimento della disoccupazione. Grandi lavori pubblici, autostrade e poi il riarmo, forniscono salari a un numero crescente di occupati.
I risultati sono, dietro le fredde cifre, spettacolari per ampiezza e rapidità.
Nel gennaio 1933, quando Hitler sale al potere, i disoccupati sono 6 milioni e passa.
A gennaio 1934, sono calati a 3,7 milioni. A giugno, sono ormai 2,5 milioni.
Nel 1936 calano ancora, a 1,6 milioni.
Nel 1938 non sono più di 400 mila.
E non sono le industrie d’armamento ad assorbire la manodopera.
Fra il 1933 e il 1936,
è l’edilizia ad impiegarne di più (più 209%),
seguita dall’industria dell’automobile (+ 117%);
la metallurgia ne occupa relativamente meno (+83%).
Nei fatti, la stampa di banconote viene evitata - o piuttosto dissimulata - con geniali tecnicismi. Di norma, nel sistema bancario speculativo, le banche creano denaro dal nulla aprendo dei fidi agli investitori; costoro, successivamente servendo il loro debito (e anzitutto pagando gli interessi alla banca), riempiono quel nulla di vera moneta - di cui la banca si trattiene il suo profitto (4), estraendo il suo tradizionale tributo dal lavoro umano. Ma naturalmente questo metodo genera inflazione, perché mette in circolazione moneta aggiuntiva; e Hitler vuole - deve - risparmiare al suo popolo, che ha già conosciuto l’esplosione inflattiva del 1922-23, un’altra disastrosa esperienza del genere.
Nel sistema hitleriano, è direttamente la Banca Centrale di Stato (Reichsbank) a fornire agli industriali i capitali di cui hanno bisogno.
Non lo fa aprendo a loro favore dei fidi; lo fa autorizzando gli imprenditori ad emettere delle cambiali garantite dallo Stato. E’ con queste promesse di pagamento (dette’ effetti MEFO ‘) che gli imprenditori pagano i fornitori.
In teoria, questi ultimi possono scontarle presso la Reichsbank ad ogni momento, e qui sta il rischio: se gli effetti MEFO venissero presentati all’ incasso massicciamente e rapidamente, l’effetto finale sarebbe di nuovo un aumento esplosivo del circolante e dunque dell’inflazione.
Di fatto, però questo non avviene nel Terzo Reich.
Anzi: gli industriali tedeschi si servono degli effetti MEFO come mezzo di pagamento fra loro, senza mai portarli all’incasso; risparmiando così fra l’altro (non piccolo vantaggio) l’aggio dello sconto. Insomma, gli effetti MEFO diventano una vera moneta, esclusivamente per uso delle imprese, a circolazione fiduciaria.
Gli economisti si sono chiesti come questo miracolo sia potuto avvenire, ed hanno sospettato pressioni dello Stato nazista, magari tramite la Gestapo, per mantenere il corso forzoso di questa semimoneta.
Ma nessuna coercizione in realtà fu esercitata.
Gli storici non hanno trovato, alla fine, altra risposta che quella che non vorrebbero dare: il sistema funzionava grazie alla fiducia.
L’immensa fiducia che il regime riscuoteva presso i suoi cittadini, e le sue classi dirigenti.
Hanno detto che Hjalmar Schacht, il banchiere centrale del Reich, ebreo, che è l’inventore del sistema, ha reso invisibile l’inflazione: gli effetti MEFO erano un circolante parallelo che il grande pubblico non vedeva e di cui forse nemmeno aveva conoscenza, e dunque privo di effetti psicologici.
In seguito Schacht (che fu processato a Norimberga ma, naturalmente, assolto) spiegò – fumosamente d’aver pensato che, se la recessione manteneva inutilizzato lavoro, officine, materie prime, doveva esserci anche del capitale parimenti inutilizzato nelle casse delle imprese; i suoi effetti MEFO non avrebbero fatto che mobilitare quei fondi dormienti. Bisogna correggere la modestia del geniale banchiere. Erano proprio i fondi a mancare nelle casse, non l’energia, la voglia di lavorare, la capacità attiva del popolo.
Schacht fece molto di più. Da ebreo, conosceva bene la frode fondamentale su cui si basa il sistema del credito, e i lucri che consente l’abuso della fiducia dei risparmiatori e degli attivi, che col loro lavoro riempiono di vero denaro i conti di denaro vuoto, contabile, che la banca crea ex-nihilo. Per una volta nella storia, un ebreo fece funzionare la frode a vantaggio dello Stato - senza lucro - e del popolo.
Non a caso, e senza nessuna intenzione sarcastica, Hitler gratificò Schacht del titolo di “ariano d’onore”: mai definizione fu meglio meritata.
Un economista britannico, C.W. Guillebaud (5), ha espresso con altre parole lo stesso concetto: “nel Terzo Reich, all’ origine, gli ordinativi dello Stato forniscono la domanda di lavoro, nel momento in cui la domanda effettiva è quasi paralizzata e il risparmio è inesistente; la Reichsbank fornisce i fondi necessari agli investimenti [con gli effetti MEFO, che sono pseudo-capitale]; l’investimento rimette al lavoro i disoccupati; il lavoro crea dei redditi, e poi dei risparmi, grazie ai quali il debito a breve termine precedentemente creato può essere finanziato [ci si possono pagare gli interessi] e in qualche misura rimborsato (6)”.
Con il denaro creato dal nulla a beneficio del popolo, anziché degli speculatori, la Germania - mentre il mondo gela nella recessione profonda degli anni ‘30 - prospera.
La massa dei salari, che ammontava a 32 miliardi di marchi nel 1932, è salita nel 1937 a 48,5 miliardi: parecchio di più della massa salariale del boom pre-1929 (42,4).
E qui gli economisti, i teorici del monetarismo e della mano invisibile del mercato, aspettano al varco l’esperimento hitleriano: quell’abbondanza di potere d’acquisto nelle tasche dei lavoratori provocherà una crescita esponenziale dei consumi, e dunque una pressione al rialzo dei prezzi. Si tenga conto che quel denaro è nelle mani di milioni di uomini e donne che sono stati disoccupati per anni, e per anni hanno vissuto nella privazione: la corsa agli acquisti di generi di consumo sarà dunque inarrestabile. Non ci sarà alcuna creazione di risparmi indicata da Guillebaud. L’inflazione sembra tanto più certa, in quanto nella Germania di Hitler, fra il 1932 e il 1937, la produzione di beni di consumo aumenta poco (+39%), specie in confronto all’enorme aumento di beni di produzione, macchinari, strade, fabbriche (+ 172%). Dunque il potere d’acquisto aggiuntivo si getterà a comprare beni relativamente scarsi, accentuando la spinta all’inflazione.
Ebbene: in Germania, l’inevitabile inflazione non si verifica.
L’indice del costo della vita, pari a 120,6 nel 1932, è nel 1937 a 125,1: in cinque anni l’inflazione sale di poco più che 4 punti.
Come mai?
Alla ricerca del trucco, gli economisti si sono chinati sul prelievo fiscale.
Certo lo Stato nazista avrà sottratto agli operai una parte notevole del loro nuovo potere d’acquisto con tributi gravosi.
In realtà, nella Germania del 1937 la percentuale del prelievo fiscale sul reddito nazionale è pari al 27,6%, appena poco di più del 26% del 1933, quando Hitler prende il potere.
Del nuovo reddito creato dalla prosperità indotta, il Reich non preleva che il 7,5%: un prelievo così mite non si è visto mai, né prima né dopo, negli Stati più liberali. E di fatto, il risparmio dei privati in quegli anni, praticamente, si quintuplica: incoraggiato dallo Stato, ma non imposto coercitivamente.
I teorici devono dunque ricorrere a spiegazioni poco scientifiche: la naturale frugalità germanica, la sua innata disciplina. Per evitare un altro termine, che spiegherebbe di più: l’entusiasmo di un popolo spontaneamente mobilitato per la propria rinascita, liberato dal giogo dei lucri bancari, che ha capito perfettamente gli scopi dei suoi dirigenti, e vi collabora con energia e creatività.




















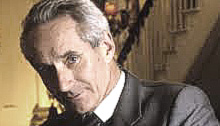

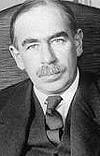











 indica gli dèi, sia maschili che femminili. È plurale numerico di "divinità".
indica gli dèi, sia maschili che femminili. È plurale numerico di "divinità". è il nome personale di un dio maschio, il personaggio principale della Bibbia.
è il nome personale di un dio maschio, il personaggio principale della Bibbia.